 Perchè gli inglesi e la loro ricerca storica, ignorano la partecipazione del Regno d’Italia nella Grande Guerra?
Perchè gli inglesi e la loro ricerca storica, ignorano la partecipazione del Regno d’Italia nella Grande Guerra?
Se chiedete all’inglese della strada neppure sa che l’Italia ha combattuto (al loro fianco) nella Grande Guerra. No, non stiamo scherzando.
Se poi portate un amico britannico a fare un’escursione sulle Alpi e gli mostrate le trincee e gallerie scavate in quota, probabile che cada dalle nuvole quando gli spiegate come mai qualcuno s’era preso la briga di fare queste opere a duemila metri d’altezza e lungo un fronte di centinaia di chilometri.
Peggio, negli ambienti accademici o
della storiografia ufficiale è di fatto rarissimo che si consideri l’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Basti pensare che la recente pubblicazione curata dall’università di Cambridge sulla storia della Grande Guerra (ben 3 volumi “The Cambridge History of the First World War”), tra le migliaia di pagine, dedica all’Italia solo uno striminzito capitolo. L’unico momento in cui vagamente i britannici si ricordano del contributo italiano è quando, al pub, scappa la battuta derisoria sullo “switching sides” ovvero il cambiare alleanze con l’Armistizio del 1943 e prima col Patto di Londra nel 1915; come a dire che di quelli sotto certe latitudini non ti puoi fidare.
Per inciso, nella Grande Guerra il contributo di sangue sul piano militare è stato simile: la Gran Bretagna ha avuto 700 mila morti (900 mila se si includono i territori dell’Impero) e l’Italia 650mila.
Senza contare che l’Italia oltre ai morti militari ha dovuto contare migliaia di morti tra i civili (per lo più friulani e veneti) deportati dagli austroungarici nei campi di prigionia durante l’anno di occupazione dopo Caporetto, che la Gran Bretagna non ha dovuto soffrire. Questo ignorare l’Italia è una questione storica ma soprattutto culturale, di non poco conto. Il 4 giugno scorso, s’è discusso di Grande Guerra all’Istituto Italiano di Cultura a Londra all’incontro dal titolo “Italy’s Great War: The experiences of soldiers on the Italian front, 1915-18”. Anche in quella sede si è sollevato il problema e anche l’archivista dell’Imperial War Museum ha ammesso che in effetti di Italia, in relazione alla Grande Guerra, in Gran Bretagna non si parla.
A livello di ipotesi, una spiegazione che è stata data durante la serata (da un relatore inglese) è che quando le truppe britanniche arrivarono in Italia si era già sul Piave (novembre 1917 - novembre 1918) e la guerra dell’Italia era ormai una guerra difensiva con relativamente poca azione ad esclusione delle tre battaglie decisive inclusa quella finale di Vittorio Veneto. Quindi, rispetto al fronte Occidentale della Francia e del Belgio, fatto di continui massacranti attacchi e contrattacchi, il Piave del 1917-18 era visto dagli inglesi come un fronte decisamente più tranquillo.
Questa sorta di relativa tranquillità è poi stata trasmessa nei resoconti in patria con il risultato che lo sforzo bellico dell’Italia fu pressoché ignorato, anche dagli Alleati inglesi, americani e francesi, al tavolo di pace a Versailles (tragicamente memorabile la scena, descritta nel libro “The Peacemakers”, del primo ministro Vittorio Emanuele Orlando che, per la frustrazione, esce piangendo dalla sala riunioni). Questa spiegazione però non soddisfa appieno.
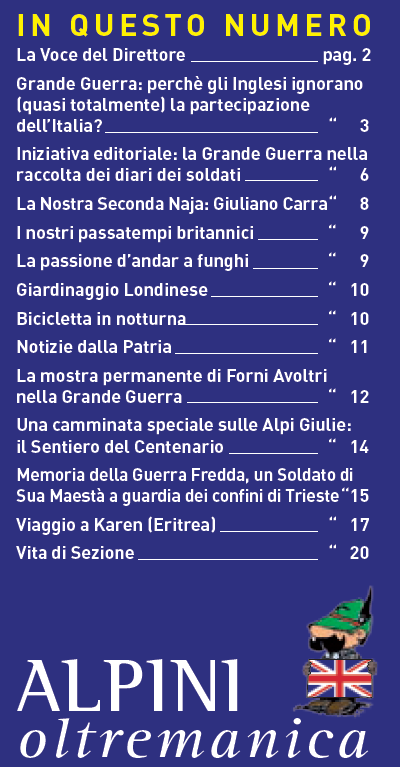 Dalle quattro chiacchiere fatte coi relatori (italiani) della serata (lo storico Marco Mondini e il giornalista storico Nicola Maranesi) si coglie che è una questione che in effetti non si è esplorata per niente: in Italia nessuno sa cosa pensino all’estero sulle nostre vicende belliche al di là di quello che è menzionato in pochissime pubblicazioni mentre all’estero pochi si preoccupano di cambiare la Dalle quattro chiacchiere fatte coi relatori (italiani) della serata (lo storico Marco Mondini e il giornalista storico Nicola Maranesi) si coglie che è una questione che in effetti non si è esplorata per niente: in Italia nessuno sa cosa pensino all’estero sulle nostre vicende belliche al di là di quello che è menzionato in pochissime pubblicazioni mentre all’estero pochi si preoccupano di cambiare la Gaspari nel suo “Le curiosità della Grande Guerra”. Dal canto nostro, da osservatori amatoriali della Storia, notiamo che il grande scrittore e all’epoca inviato del Daily Telegraph Rudyard Kipling, fu mandato sul fronte alpino italiano e ne descrisse alcuni aspetti (vedi Messaggero Veneto del 2011: “Quando Kipling vide e raccontò la Grande Guerra”) poi messi nero su bianco in una serie di scritti oggi raccolti in un libro (“La guerra nelle montagne. Impressioni dal fronte italiano” ed. Mursia).
Dalle quattro chiacchiere fatte coi relatori (italiani) della serata (lo storico Marco Mondini e il giornalista storico Nicola Maranesi) si coglie che è una questione che in effetti non si è esplorata per niente: in Italia nessuno sa cosa pensino all’estero sulle nostre vicende belliche al di là di quello che è menzionato in pochissime pubblicazioni mentre all’estero pochi si preoccupano di cambiare la Dalle quattro chiacchiere fatte coi relatori (italiani) della serata (lo storico Marco Mondini e il giornalista storico Nicola Maranesi) si coglie che è una questione che in effetti non si è esplorata per niente: in Italia nessuno sa cosa pensino all’estero sulle nostre vicende belliche al di là di quello che è menzionato in pochissime pubblicazioni mentre all’estero pochi si preoccupano di cambiare la Gaspari nel suo “Le curiosità della Grande Guerra”. Dal canto nostro, da osservatori amatoriali della Storia, notiamo che il grande scrittore e all’epoca inviato del Daily Telegraph Rudyard Kipling, fu mandato sul fronte alpino italiano e ne descrisse alcuni aspetti (vedi Messaggero Veneto del 2011: “Quando Kipling vide e raccontò la Grande Guerra”) poi messi nero su bianco in una serie di scritti oggi raccolti in un libro (“La guerra nelle montagne. Impressioni dal fronte italiano” ed. Mursia).
Il problema a livello di “immagine” di questi racconti è che forse hanno dato al pubblico inglese una visione edulcorata della guerra dell’Italia: gli Alpini che scalano una montagna con corde e piccozze ovvero, come intenti semplicemente a fare “alpinismo”, uno sport all’epoca appannaggio delle élites aristocratiche e borghesi (in buon numero proprio inglesi!), più che a morire sotto il fuoco nemico in sanguinosi scontri.
Tra l’altro, secondo le statistiche che cita il Gaspari sempre in “Le curiosità della Grande Guerra”, a livello di morti “in battaglia” il fronte del Carso falciò ben il 22% dei soldati impegnati nei combattimenti (essenzialmente della Fanteria) mentre sul fronte alpino “solo” l’11% (il resto, pur numeroso, dei caduti in montagna furono vittime di valanghe, congelamento e malattie legate all’esposizione ad intemperie). Insomma, quello che descrisse Kipling non era il fronte “giusto” per dare un’immagine di quella che fu la guerra dell’Italia, ovvero il Carso: una distesa di rocce da percorrere in salita in cui era impossibile usare il badile per scavare trincee, soggetto ad una cronica mancanza d’acqua potabile, con pietre le cui schegge moltiplicavano l’effetto delle esplosioni e senza ripari naturali di fronte alle moderne mitragliatrici da 400 colpi al minuto.
Francamente uno scenario infernale che non ha nulla da invidiare al fango del Western Front!
Paradossalmente, non aiutano neppure le pagine dell’americano Ernest Hemingway che arrivò in Italia nel 1918 inquadrato nella Croce Rossa Americana alle falde del Pasubio (nelle retrovie) e poi, brevemente, sul Piave dove fu ferito.
Le informazioni che ha sul fronte più cruento, quello dell’Isonzo del 1915-17, secondo quanto scritto ne “Il combattimento di Pradamano” da Paolo Gaspari, gli arrivano dall’infermiera inglese Agnes Conway. Informazioni che poi utilizzò per alcuni stralci del romanzo “A Farewell to Arms” (“Addio alle Armi”). La Conway (da non confondere con Agnes von Kurowsky, infermiera americana di cui si innamorò e che ispirò poi il personaggio dell’infermiera “Catherine Barkley”) prima di essere assegnata all’ospedale della Croce Rossa Americana di Milano, era dislocata presso l’ospedale della Croce Rossa Britannica di Dolegnano (oggi in comune di San Giovanni al Natisone) all’epoca a ridosso del fronte della II Armata italiana che fronteggiava gli austroungarici da Plezzo (Bovec) a Gorizia. Secondo Gaspari, qui la Conway avrebbe appreso le informazioni sugli scontri sanguinosi sull’Isonzo dai barellieri e da vario personale di prima linea oltre che all’aver vissuto in prima persona lo sbandamento e la ritirata di massa dopo lo sfondamento tedesco/austroungarico a Caporetto.
I dettagli dell’attraversamento del ponte (sul fiume “Torre”) sono poi ripresi nel romanzo da Hemingway con rilievi molto verosimili che però lui non verificò in prima persona ma, sempre secondo il Gaspari, riprese dai racconti (evidentemente dettagliati) della Conway. Però anche qui le vicende sono state mostrate al pubblico anglosassone con la formula molto addolcita del romanzo d’amore e per di più in chiave antimilitarista, che altro non fa che sminuire l’idea di un contributo importante dell’Italia alla causa degli Alleati dell’Intesa.
A questo punto entra in gioco il “pezzo da novanta”. Il Gaspari menziona il fatto che la Agnes Conway, a Dolegnano, era alle dipendenze del capo dell’Ospedale della Croce Rossa Britannica... tale George Macaulay Trevelyan! Trevelyan è stato uno dei più conosciuti e rispettati storici inglesi e dall’esperienza sul fronte italiano durante la guerra, trasse il libro “Scenes from Italy’s war”.
Ebbene, a questo punto c’è da chiedersi come mai uno storico così importante non abbia elaborato ulteriormente sulla Guerra in Italia.
Come mai negli anni del primo dopoguerra non è andato oltre il suo libro sul fronte italiano con studi più approfonditi e magari divulgativi?
Grazie ai contatti che aveva stabilito in Italia tra i militari e probabilmente anche con i borghesi, avrebbe avuto materiale di prima mano per descrivere gli eventi. Il solo monte San Michele (in realtà un colle di 275 metri), alle porte di Gorizia, a neppure 20 km da Dolegnano, costò la vita a 20mila italiani.
Carneficine del genere sono pari a quelle del Western Front, e probabilmente, numeri alla mano, pure peggiori. Cos’è mancato in termini di dedizione ed eroismo agli Italiani di fronte a certi numeri? Sebbene con molte pecche sul piano della tecnica militare antiquata degli Alti Comandi, c’erano state pure vittorie con la conquista di Gorizia e l’avanzata verso la Bainsizza. Perché limitare la narrazione di questi eventi?
A proposito, se ci permettete la divagazione nella mondanità dell’epoca, l’ospedale, la cui sede era nella villa dei conti Trento a Dolegnano, era diventato un “angolo di Britannia” frequentato dalla moglie del duca Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta (il Duca d’Aosta, comandante della III Armata), la duchessa Elena d’Orleans.
La duchessa era l’ispettrice generale delle infermiere volontarie Croce Rossa Italiana ma la sua frequentazione a Dolegnano era, verosimilmente, dovuta al fatto che lei stessa era nata a Twickenham, poco fuori Londra, dove la sua famiglia (di regnanti francesi) fu costretta all’esilio dopo i fatti parigini del 1848.
Di fatto era cresciuta come una vera e propria nobildonna inglese, il matrimonio con il duca era avvenuto nel 1895 a Kingston upon Thames e i figli Amedeo (che sarà poi nel 1941 l’eroe dell’Amba Alagi) e Aimone, studiarono al prestigioso college della nobiltà britannica, Eton. Tra l’altro Amedeo, poco più che sedicenne, servì come volontario nel reggimento di artiglieria a cavallo “Voloire” e fu destinato alla prima linea come servente d’artiglieria sul Carso.
Secondo le cronache della storia ufficiale, qui servì come caporale senza privilegi ed arrivò a guadagnarsi i gradi di tenente sul campo. Suo fratello da giovanissimo ufficiale di marina fu pilota di idrovolanti.
Ci pare strano che a Trevelyan non siano giunte le testimonianze dei drammi della guerra dell’Italia sul fronte carsico da parte della duchessa Elena che, nella sua veste di ispettrice della Croce Rossa, di ospedali ne doveva aver visitati. Come pare strano che non gli fossero siano giunte notizie di prima mano da parte del Duca d’Aosta e di suo figlio Amedeo vista la frequentazione con la duchessa. Con tutte queste informazioni possibile non riflettere la drammaticità della guerra che era evidentemente ben più di una semplice vacanza sulle Alpi e nelle villedelle campagne friulane?
Da considerare c’è anche il fatto che secondo il Gaspari, a Dolegnano, nello stesso ospedale di Trevelyan, come infermiera c’era anche l’anglo-italiana Freya Stark, la madre di quello che divenne poi il genere letterario del travel writing.
Aggiungiamo poi che esistono moltissime lettere dal fronte italiano inviate dagli inglesi che combatterono in Italia (ad esempio quelle depositate all’Imperial War Museum di Londra) e sono lettere lusinghiere nei confronti dei locali fratelli in armi.
Tuttavia non pare siano state mai raccolte in pubblicazioni specifiche.
Si può comunque citare il diario di guerra di un soldato inglese che effettivamente riconosce l’importanza del fronte italiano (forse proprio perché c’aveva combattuto da ufficiale d’artiglieria), e che in questo senso è senz’altro controcorrente: Dalton Hugh, “With the British Guns in Italy, a tribute Italian Achievement”.
Edito inizialmente nel 1919 e ripubblicato da Forgotten Books nel 2012, si può acquistare su internet ed è anche è un bel libro da leggersi. Da sottolineare che Hugh fu parlamentare del Labour Party nel primo dopoguerra e che quindi doveva essere egli stesso un nome noto al grande pubblico britannico.
Ci sarebbe anche da annotare quanto scoperto in alcuni carteggi, dallo storico dell’università di Cambridge Peter Martland che portò alla luce come, subito dopo Caporetto, Benito Mussolini ricevette un cospicuo stipendio settimanale dal servizio segreto britannico, l’MI5, su indicazione di Samuel Hoare, futuro ministro degli esteri, all’epoca agente dell’intelligence britannica in Italia (famoso nel 1935 per l’accordo Hoare-Laval che darà di fatto all’Italia il controllo dell’Abissinia).
L’Inghilterra voleva sincerarsi che i giornali interventisti come “Il Popolo d’Italia” diretto dal futuro dittatore, continuassero ad infiammare l’opinione pubblica a sostegno della guerra, scongiurando così il collasso del “fronte interno” com’era accaduto in Russia.
La notizia è saltata agli onori delle cronache nel 2009, dalla BBC ai maggiori quotidiani di Londra; ma mentre è di interesse per i tecnici della storia, per i più è stata l’ulteriore nota di costume sul Belpaese e nulla più. Insomma, possibile che tanta potenza di fuoco giornalistico-letterario non abbia fatto trasparire all’opinione pubblica britannica il tremendo contributo di sangue dell’Italia?
L’immagine dell’Italia come nazione marginale nella Grande Guerra da parte dell’opinione pubblica e degli storici britannici, sicuramente è figlia di tanti fattori. Di certo dobbiamo tener conto che gli interessi di politica estera ed economica che Regno Unito e Francia avevano nel primo dopoguerra spingevano a sottovalutare artificialmente, e quindi nel far sottovalutare, il contributo dell’Italia alla guerra, per facilitare il ridimensionamento delle richieste italiane (in particolare per l’Inghilterra, non era accettabile una eccessiva espansione dell’egemonia marittima italiana sul Mediterraneo). Inoltre, verosimilmente si tratta di una questione legata agli anni Venti e Trenta, in concomitanza dell’ascesa del regime Fascista, ma la cui onda lunga probabilmente si è ripercossa nella cultura e nella storiografia ufficiale degli anni successivi, peraltro tenendo anche conto che nella II Guerra Mondiale l’Italia era avversaria dell’Inghilterra e quindi c’erano motivi ulteriori per detrarre il contributo dell’antico ex alleato italiano. Appena uscito ad ottobre 2015 è “Allies are a tiresome lot’. The British Army in Italy in the First World War” di John Dillon che però sembra perpetrare il consueto atteggiamento volto a minimizzare quanto fatto dagli Italiani nella guerra, sebbene ha il merito quantomeno di ammettere che fino ad oggi questo contributo italiano sia stato ignorato nel mondo anglosassone. Dillon punta il dito sugli storici militari italiani dell’era fascista che avrebbero ridimensionato volutamente il ruolo delle truppe francesi ed inglesi sul fronte del Piave enfatizzando oltre il dovuto quello del Regio Esercito. Questo evidentemente irritò (ed irrita) gli studiosi d’Oltremanica che, evidentemente, fecero lo stesso a parti invertite. Poi l’alleanza con la Germania di Hitler degli anni Trenta chiuse le porte ad ogni possibile mutual understanding tra storici e non.
Tant’è che per un secolo fior fiore di giornalisti e storici britannici non son riusciti a testimoniare equamente lo sforzo italiano nella Grande Guerra, sia militare che sociale. L’opera monumentale di Mark Thompson e i vari libri pubblicati in occasione del Centenario si spera siano solo l’inizio ma toccherà ai nostri storici (e diplomatici?) contribuire a interrompere un secolo di oblio tra gli anglosassoni sul contributo italiano alla Prima Guerra Mondiale. Dopotutto, 650mila morti, caduti al fronte anche per compiacere gli allora piani dell’Impero Britannico, lo meritano.
Fabrizio Biscotti - Alpini oltremanica, periodico della Sezione ANA Gran Bretagna - Anno XLII - n° 74 - Dicembre 2015